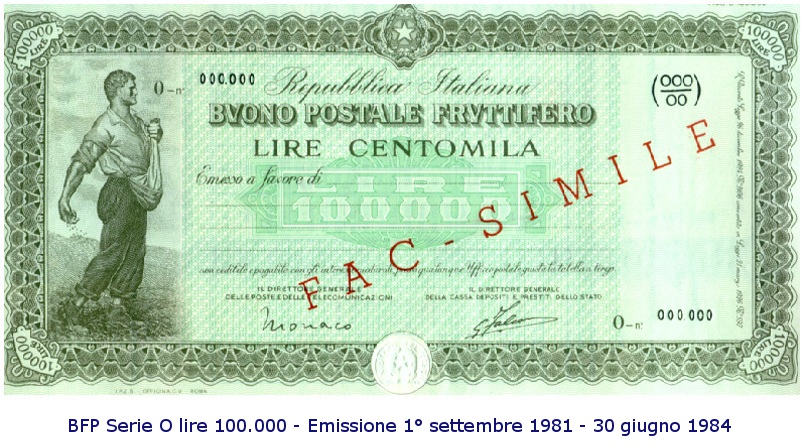Francesco Cossiga, statista, 1928-2010
24 Agosto 2010LA POLITICA E LA BALENTÌA – © Francesco D. Caridi
A Francesco Cossiga, lo statista che previde gli esiti della dissoluzione del vecchio equilibrio di Yalta e decise di scoperchiare il vaso delle dissimulazioni e dei misteri difendendo però le ragioni superiori (politiche e storiche, italiane e internazionali) che motivarono le schermature di Stato rispetto ad accadimenti drammatici in periodi di forti tensioni tra potenze (la Guerra Fredda), una generazione di cronisti parlamentari deve molta riconoscenza.
È di Cossiga, infatti, il merito di aver maggiormente contribuito, dopo la cessazione dell’ipoteca comunista e sovietica sull’Europa, a liberare un certo giornalismo dai prudenti esercizi di autocensura, offrendo notizie e interpretazioni clamorose al mondo della informazione, in genere prima vincolato alle veline ufficiali, con qualche eccezione (a destra, Il Borghese, che nel periodo in cui vi scrivevo fu molto vicino a Cossiga, e a sinistra L’Espresso). La libertà di pubblicare articoli dissacranti e veritieri soprattutto verso i camaleonti democristiani e comunisti, rigeneratisi sotto altre sigle dopo la caduta del Muro di Berlino, era avallata dalla più alta carica dello Stato che garantiva con le sue esternazioni l’autenticità dei fatti svelati grazie alle sue testimonianze e ai suoi suggerimenti, che talvolta pervenivano in modo eccentrico (letterine firmate con pseudonimi recapitate da motociclisti del Quirinale).
Nell’estate del 1990, Cossiga annunciò di voler «togliersi i primi sassolini dalle scarpe», buttando nel panico il fior fiore dei professionisti di centro e di sinistra a lui avversi, che lo presero per matto. La «lepre marzolina» cominciò a rendere così un servigio alla verità storica e quindi alla comprensione di vicende non sempre limpide. E si applicò nel contempo ad un esercizio di autoanalisi («C’è del metodo in questa follia», diceva Amleto), per trasformare la sua inquietudine e i suoi rimorsi che lo mandavano in depressione in un ultimo servizio alla Patria, di cui fu uno dei massimi difensori sotto le bandiere della Democrazia Cristiana, in una singolare posizione di uomo della sinistra del cattolicesimo politico che però accoglieva e sosteneva il realismo della destra sullo scacchiere interno ed estero.
Quando il PCI cercò di metterlo all’angolo sul caso «Gladio», la formazione segreta paramilitare antisovietica emanazione della NATO organizzata da Moro e Taviani, Cossiga, fregandosene dell’etichetta, convocò una sera di ottobre del 1991 Massimo D’Alema al Quirinale ammonendolo senza giri di parole: «Abbiamo saputo da ufficiali del KGB fedeli a Eltsin che voi siete coinvolti nell’esportazione clandestina di valuta», come riferì Valerio Riva nel suo libro L’Oro di Mosca. D’Alema (che sarebbe stato poi portato dallo stesso Cossiga alla Presidenza del Consiglio, per fargli condividere le operazioni di guerra della NATO contro i Serbi nel Kosovo, facendo digerire ai post-comunisti la nuova strategia militare americana perfino fuori delle clausole convenzionali) capì che con Cossiga era inutile fare i gradassi, perché con un sol colpo sparato dal Quirinale sarebbero crollate le soffitte di Botteghe Oscure.
La verità, irriverente per natura, reca dispetto al galateo, che nella pratica politica corrisponde alla ipocrisia e spesso alla menzogna.
Chi volesse leggere le vicende nazionali e mondiali dietro le quinte e senza le mediazioni accademiche, ha disponibili in libreria alcuni testi che riportano il pensiero sincero di Cossiga: Per carità di patria, edito da Mondadori nel 2003, e La passione e la politica, edito da Rizzoli nel 2000. E chi volesse continuare a godere della verve, della cultura e del coraggio dello statista, che utilizzò anche lo sberleffo per castigare usi e costumi dei suoi colleghi sempre chiamati ironicamente «illustri ed onorevoli», legga l’ultimo suo libro di testimonianza: Fotti il potere (sottotitolo: Gli arcana della politica e dell’umana natura), edito da Aliberti nel mese di maggio scorso.
Poi è venuto il silenzio, motivato dal fatto di sentirsi fisicamente allo stremo (aveva somatizzato con la canizie, la vitiligine, il cancro e disturbi anche psichici la tragedia del suo amico Aldo Moro, che egli da Ministro dell’Interno non riuscì a liberare dalla prigionia delle Brigate Rosse) e di dover prepararsi spiritualmente, come diceva lui stesso, «al grande incontro» con il Padre Eterno, ripulendosi delle scorie mondane. Anche le verità terrene venivano così confinate nel girone delle vanità; il confronto sarebbe avvenuto d’ora innanzi soltanto con il confessore, la libertà di coscienza si genufletteva di fronte agli imperativi della Fede e le armi del vecchio indomito combattente si deponevano incondizionatamente con la richiesta di perdono soprattutto, presumo, per i peccati di orgoglio. Ché verso i nemici ideologici e verso molti compagni del suo partito che pure l’avevano insultato, fu alla fine sempre clemente e misericordioso: mai fece il maramaldo, pur divertendosi a torturarli con le battute fulminanti.
In quest’Uomo di carattere, figlio di uno dei fondatori del Partito Sardo d’Azione, imparentato con due grandi famiglie della politica (i Segni e i Berlinguer), cattolico «infante» come si definì in opposizione ai presuntuosi cattolici «adulti» che vorrebbero piegare la Chiesa al relativismo etico, costituzionalista apprezzato anche dalle università anglosassoni, studioso di Tommaso Moro e seguace del pensiero del cardinale inglese Newman, al pari di Giulio Andreotti amico ed interlocutore richiesto ed apprezzato di tre Papi (Paolo VI, sua guida alla FUCI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI), c’era la fierezza della origine in una isola asperrima che lui esaltava, assumendo per provocazione a proprio modello di condotta la «balentìa» sarda (coraggio virile e senso dell’onore), che somiglia all’antica «andraghatìa» calabrese: «Io sono italiano perché la mia identità culturale e nazionale è quella italiana; e sono fiero di essere sardo, anche perché porto all’essere italiano la ricchezza di essere sardo».